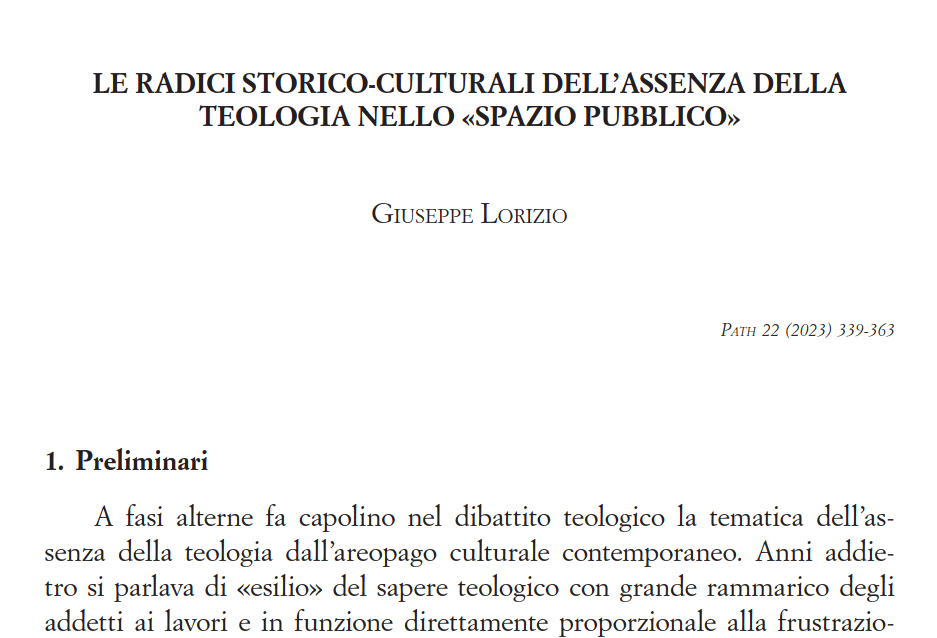La domanda che ci ha guidato nell’Epifania si può così formulare: come possiamo orientarci nel tempo del disorientamento e della notte del mondo? Chi o cosa guida il pellegrino nel viaggio verso la porta santa? La parola anzi la voce può compiere il miracolo dell’orientamento, per cui non ci perdiamo e non periamo. Si tratta di una voce che si ascolta, ma anche che, in quanto destinata ad orientare, addirittura si vede: «Il popolo vide la voce» (Es 20,18) e il narrante si volta per “vedere la voce” (Ap 1,12). «L’espressione – scriveva l’alessandrino Filone – è altamente significativa. La voce umana è fatta per essere ascoltata, ma la voce di Dio è verità che dev’essere vista. Per quale motivo? Perché ciò che Dio pronuncia non sono parole, ma opera, che l’occhio discerne meglio dell’orecchio». Il tentativo, rischioso e affascinante di far dialogare Atene e Gerusalemme, la cultura dell’ascolto e della parola con quella della visione e del concetto, conserva ancora una sua validità, a causa della perenne ansia che abita chi lo ripropone, senza rassegnarsi di fronte al dilemma di inquietanti e fallaci alternative. Il nostro tempo è il tempo della povertà, ed è diventato tanto povero da non avvertire la mancanza di Dio come mancanza: «La mancanza di Dio significa che non c’è più nessun Dio che raccolga in sé, visibilmente gli uomini e le cose, ordinando in questo raccoglimento la storia universale e il soggiorno degli uomini in essa. Ma nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di peggiore ancora. Non solo gli Dei e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà perché diviene sempre più povero» (così Martin Heidegger). Nella postmodernità si realizza e si esprime in termini eclatanti quel fenomeno della “perdita del centro”, che Hans Sedlmayr aveva così efficacemente descritto, assumendo come sintomo dell’epoca il messaggio proveniente dalle arti figurative degli ultimi due secoli e che Oswald Spengler aveva, con espressione felice e coraggiosa, denominato “tramonto dell’Occidente”. L’epoca del disorientamento registra come propria componente non marginale e non meramente epistemologica la frammentazione del senso e del sapere che in esso si produce. Come scrive la Fides et ratio: «E’ da osservare che uno dei dati più rilevanti della nostra condizione attuale consiste nella “crisi del senso”. I punti di vista, spesso di carattere scientifico, sulla vita e sul mondo si sono talmente moltiplicati che, di fatto, assistiamo all’affermarsi del fenomeno della frammentarietà del sapere» (n. 81). In questo contesto di “disperazione epistemologica” e di “dispersione antropologica”, un messaggio particolarmente illuminante le tenebre della notte del mondo è quello che promana dall’espressione che Franz Rosenzweig ha adottato come leitmotiv della propria riflessione e Giovanni Paolo II ha incastonato nella Fides et ratio (n. 15): «Si tratta del mio punto di Archimede in filosofia, che cercavo da lungo tempo […]. Rivelazione è orientamento. Dopo la rivelazione nella natura c’è un “alto” e un “basso”, reale, non più relativizzabile: “cielo” e “terra” […] e nel tempo c’è un “prima” e un “dopo”, reale, stabile. Quindi nello spazio naturale e nel tempo naturale il centro è sempre il punto in cui io in quel momento sono; nello spaziotempo-mondo rivelato il centro è invece un punto fisso inamovibilmente, un punto che non sposto se io stesso mi trasformo o mi allontano: la terra è il centro del mondo e la storia universale si estende prima e dopo Cristo». Detto anzi scritto da un pensatore ebreo non è poco!