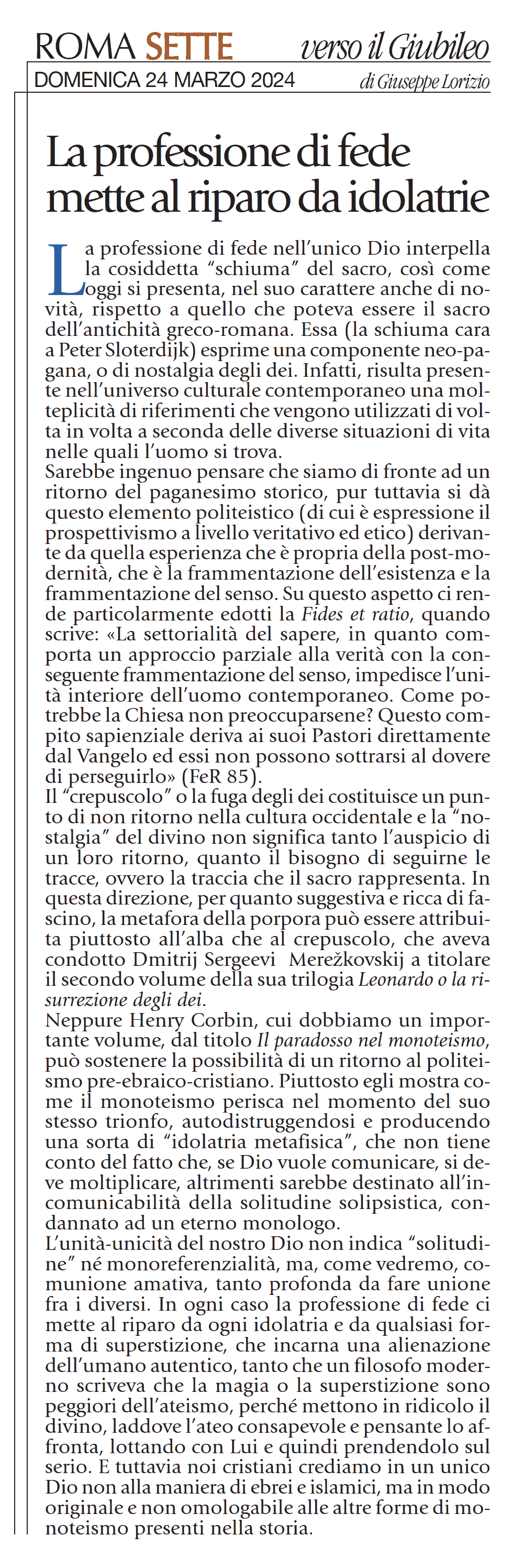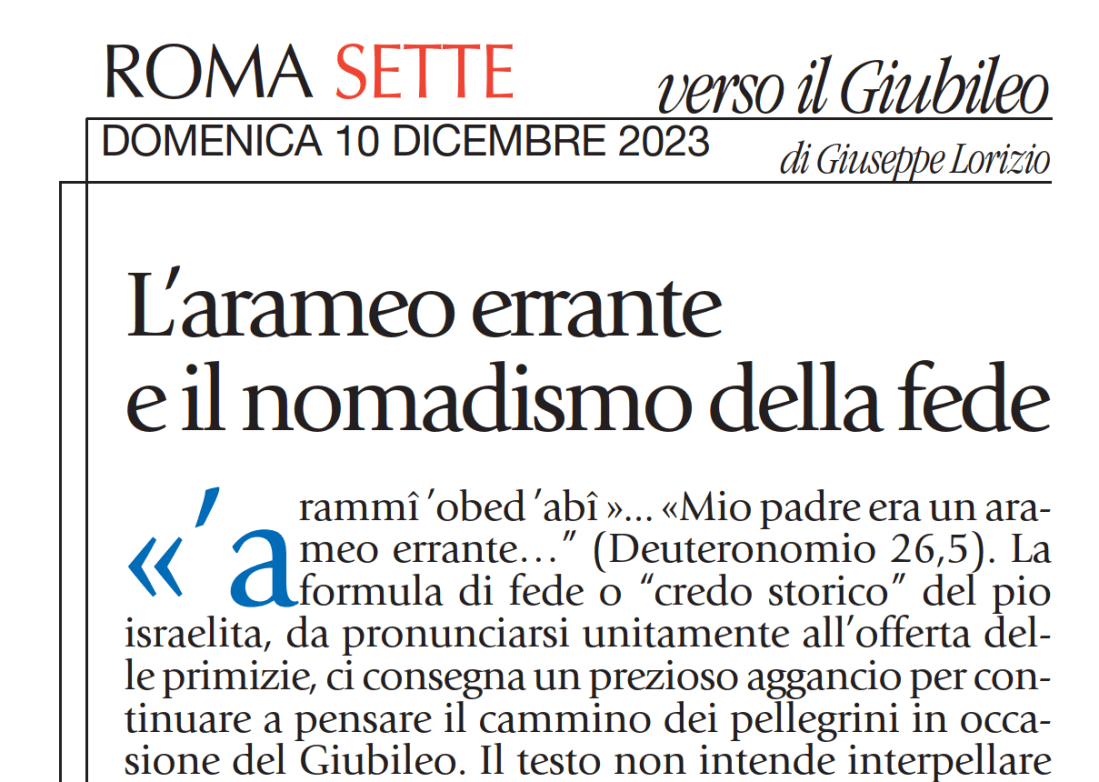Di Marco Staffolani su Avvenire Roma 7, 17 Novembre 2024.
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio…» Lc 6,17.20-26
Queste frasi del Vangelo mi hanno sempre messo in difficoltà perché ogni volta che si presentano nella liturgia, sulla bocca di qualche amico, con la presenza di qualcuno povero per davvero, suscitano domande e chiedono risposte concrete, da dare nella vita personale e nel contesto socioculturale che si abita.
L’orizzonte di comprensione delle affermazioni lucane non può che essere paradossale, cioè non si trova nel quieto vivere con le sue regole e comprensioni del mondo, ma nella prospettiva di una “chiesa in uscita”, anche da sé stessa, che si mette in cammino verso l’orizzonte ampio di Dio, che lascia sempre spazio alla libertà dell’uomo.
Continua a leggere: Creativi ed inclusivi per essere accanto ai poveri.Che significa allora andando “verso il Giubileo”, in data 17 Novembre 2024, in cui si celebra l’VIII giornata mondiale per i poveri, questa presenza di coloro che Gesù proclama beati, e che papa Francesco ci ricorda al n. 16 della Spes non confundit?
Nella nostra società del benessere (e delle disuguaglianze) una condizione di povertà, di mancanza, non è di per sé desiderabile, ad esempio nell’interpretazione classica di chi non ha il pane quotidiano, un luogo dove dormire, di disporre di denaro. Il “peccato” sta nel pensare tali povertà come il problema di qualcuno, o come categorie che possono (o peggio devono) essere isolate.
Il vangelo ci sfida a superare ogni divisione umana, e comprendere che la reale condizione dell’uomo è intrinsecamente povera, e questo è voluto da Dio che ci fa esistere come creature, da lui dipendenti. Ognuno di noi, oltre che del pane, ha bisogno di Lui come senso profondo dell’esistenza, e ancor di più per salvarsi dalla chiusura in sé, nei propri egoismi.
Per converso, la vera ricchezza da raggiungere è oltre lo spazio e il tempo, anche se è già possibile attingerne misteriosamente nell’hic et nunc: il regno di Dio, quello in cui dimora la giustizia, è già in mezzo a noi, magari se non lo si vede è proprio nei poveri come germoglio che aspetta per moltiplicarsi.
Ecco allora la scoperta a cui ci porta il Vangelo: la povertà è una condizione che viviamo tutti, è il nostro essere lontani da Dio, che non sappiamo nemmeno misurare, ma che non ci lascia disperati in quanto tale nostra povertà è stata assunta anche dal Figlio, Gesù Cristo.
Proviamo allora a trarne giovamento piuttosto che viverne il lamento. Sappiamo vedere il rimando al “mezzo gaudio” che ci accomuna tutti? La povertà evangelica non crea distinzioni piuttosto invita alla conversione personale e comunitaria, verso Colui che si è identificato nei poveri, e che giudicherà alla fine dei tempi in merito a quanto è stato fatto loro, come se fosse stato fatto a Lui (mt 25,31-46).
In questo quadro della “buona novella” si comprende perché agire a favore di “chi ha di meno”, senza ridurre la povertà ad un problema di etica astratta o di “perbenismo sociale”, pacificando la coscienza con azioni isolate, mosse da circostanze emotive. Papa Francesco ci ricorda di «dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione» (Messaggio per la V giornata mondiale dei poveri 14 novembre 2021, n.6). Che lo Spirito Santo ci faccia essere creativi e inclusivi, per non escludere nessuno, in quanto nessuno è così povero da non poter dare assolutamente nulla agli altri.